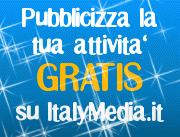Com'è piccola la Farnesina
- Dettagli
di Lucio Caracciolo
Tutti parlano di globalizzazione. Pochi in Italia si interessano del globo. Soprattutto nella classe politica. Qualsiasi governo della cosiddetta Seconda Repubblica parte con questo notevole svantaggio quando si tratta di delineare una strategia di politica estera, che infatti non è oggetto di dibattito né a destra né a sinistra, salvo l'esiguo drappello degli addetti ai lavori. La priorità di politica estera del governo di centro-sinistra sarà quindi di ridarle quella centralità che le spetta per quanto conta nella vita del paese e di ciascuno di noi. A meno di non immaginare un'Italietta autarchica, sigillata contro ogni influenza esterna, che non è e non può essere. Quando si denuncia la perdita di competitività del nostro paese su scala europea e mondiale, si ammette implicitamente un deficit non solo economico, ma anche politico. Perché l'Italia non ha mai contato di meno al mondo da quando esiste come Stato unitario. Non ha voce nei luoghi dove si decide, né dispone di un sistema di lobby per incidere sulle scelte altrui. Se la politica e la diplomazia vogliono servire i nostri interessi e ridurre il gap competitivo che ci divide da paesi di dimensioni demografiche ed economiche simili alle nostre, di qui converrà ricominciare.
L'altra premessa indispensabile a riacquistare influenza nel mondo è la ricerca di un approccio bipartisan alle grandi scelte internazionali, specie quando si tratta di pace o di guerra. Non per nascondere le divergenze, ma per evitare che sui temi strategici, che investono frontalmente gli interessi fondamentali della nazione, la politique politicienne prevalga su ogni altra considerazione. Producendo una cacofonia devastante per la nostra stessa credibilità.
Nel concreto, la politica estera del governo Prodi si qualificherà previdibilmente su due scacchiere: Europa e Medio Oriente. Vediamo come.
Il centro-sinistra e Prodi personalmente esibiscono un pedigree europeista. Oggi che l'europeismo è in crisi profonda, se non terminale, sarà comunque inevitabile rivedere il nostro modo di stare in Europa. Non perché l'Italia debba rinunciare all'obiettivo dell'unità europea. Al contrario, perché lo deve perseguire. E nel contesto attuale questo significa invertire la rotta attuale in seno all'Unione europea riassumibile nel motto ognuno per sé e nessuno per tutti.
Se vogliamo che il global player europeo su cui ha sempre insistito Prodi diventi realtà, dobbiamo renderci protagonisti di una nuova iniziativa che miri a questo scopo, insieme ai nostri partner più stretti, a cominciare da Germania e Francia. Altrimenti l'alternativa sarà tra la progressiva disintegrazione e un Euronucleo senza di noi. Questa è fra l'altro la via maestra per pesare di più nei rapporti con l'America. Contrariamente a ciò che pensa Berlusconi, la diplomazia personale serve a poco. Soprattutto se non esprime una strategia nazionale. Continuando a presentarci a Washington in ordine sparso, noi europei non abbiamo poi alcuna possibilità di dare corpo a un effettivo rapporto transatlantico, essendosi ormai consumato quello fondato per quasi mezzo secolo sulla paura di Mosca.
Più immediate le scelte sullo scacchiere mediorientale. Qui le emergenze sono tre: Iraq, Iran e Palestina. Tre facce dello stesso problema, ossia che cosa fare della regione dopo che la campagna americana contro Saddam ne ha definitivamente minato gli equilibri. Qui ci scontriamo con un doppio limite: la storica ininfluenza dell'Europa, malgrado i soldi investiti in programmi più o meno commendevoli; e la più recente mancanza di una strategia americana, particolarmente grave in un paese leader che ha deciso di reagire all'11 settembre rovesciando i regimi nemici o comunque infidi nel mondo islamico. Ma senza sapere bene come sostituirli con regimi più democratici e contemporaneamente più filoamericani.
Sull'Iraq esiste un consenso di fondo fra gli schieramenti politici sulla necessità di riportare a casa i soldati entro l'anno. Non è di per sé una strategia, ma almeno è una scelta. Ma il diavolo sta nel dettaglio. Sarà solo un cambio di cappello fra una missione militare e una civile, con una copertura militare comunque non indifferente? Quando toccherà esaminare questo capitolo, probabilmente le differenze in seno al centro-sinistra riesploderanno. Sarebbe utile prevenire una simile crisi, definendo pubblicamente che cosa esattamente stiamo a fare in Iraq e con quali mezzi - anche finanziari - intendiamo sostenere i nostri obiettivi.
Quanto all'Iran, siamo brillantemente riusciti ad autoescluderci dalla pattuglia europea abilitata a trattare con Teheran. Per un paese che intrattiene notevoli, storici rapporti energetici e commerciali con i persiani, è un autogol. Oggi potremmo usare la nostra residua influenza in Europa e in America per spingere a favore di negoziati diretti irano-americani, sola alternativa praticabile e forse efficace all'avventura bellica.
Infine la Palestina. La demonizzazione del nuovo governo palestinese, dopo che abbiamo giustamente insistito sulla necessità di lasciar esprimere quel popolo alle urne, è particolarmente miope. Perché la vittoria di Hamas è soprattutto la sconfitta di una vecchia, corrotta nomenklatura - quella arafattiana - che non poteva in nessun modo essere un interlocutore negoziale perché non rappresentava davvero il suo popolo. Se eviteremo di metterlo all'angolo, scopriremo che il governo attuale è molto meno radicale e molto più pragmatico di quanto non appaia a una lettura superficiale del voto palestinese, espresso fra l'altro da quelle stesse persone che l'anno prima avevano scelto Abu Mazen.
Dopo l'esperienza piuttosto deprimente degli ultimi anni forse è troppo ottimistico sperare che l'Italia si riprofili nella competizione internazionale in modo così netto e autorevole. Ma il tempo lavora contro di noi. Perché recuperare una credibilità perduta sarà forse l'opera di due o tre generazioni. E qualcuno dovrà pur cominciare.
L'altra premessa indispensabile a riacquistare influenza nel mondo è la ricerca di un approccio bipartisan alle grandi scelte internazionali, specie quando si tratta di pace o di guerra. Non per nascondere le divergenze, ma per evitare che sui temi strategici, che investono frontalmente gli interessi fondamentali della nazione, la politique politicienne prevalga su ogni altra considerazione. Producendo una cacofonia devastante per la nostra stessa credibilità.
Nel concreto, la politica estera del governo Prodi si qualificherà previdibilmente su due scacchiere: Europa e Medio Oriente. Vediamo come.
Il centro-sinistra e Prodi personalmente esibiscono un pedigree europeista. Oggi che l'europeismo è in crisi profonda, se non terminale, sarà comunque inevitabile rivedere il nostro modo di stare in Europa. Non perché l'Italia debba rinunciare all'obiettivo dell'unità europea. Al contrario, perché lo deve perseguire. E nel contesto attuale questo significa invertire la rotta attuale in seno all'Unione europea riassumibile nel motto ognuno per sé e nessuno per tutti.
Se vogliamo che il global player europeo su cui ha sempre insistito Prodi diventi realtà, dobbiamo renderci protagonisti di una nuova iniziativa che miri a questo scopo, insieme ai nostri partner più stretti, a cominciare da Germania e Francia. Altrimenti l'alternativa sarà tra la progressiva disintegrazione e un Euronucleo senza di noi. Questa è fra l'altro la via maestra per pesare di più nei rapporti con l'America. Contrariamente a ciò che pensa Berlusconi, la diplomazia personale serve a poco. Soprattutto se non esprime una strategia nazionale. Continuando a presentarci a Washington in ordine sparso, noi europei non abbiamo poi alcuna possibilità di dare corpo a un effettivo rapporto transatlantico, essendosi ormai consumato quello fondato per quasi mezzo secolo sulla paura di Mosca.
Più immediate le scelte sullo scacchiere mediorientale. Qui le emergenze sono tre: Iraq, Iran e Palestina. Tre facce dello stesso problema, ossia che cosa fare della regione dopo che la campagna americana contro Saddam ne ha definitivamente minato gli equilibri. Qui ci scontriamo con un doppio limite: la storica ininfluenza dell'Europa, malgrado i soldi investiti in programmi più o meno commendevoli; e la più recente mancanza di una strategia americana, particolarmente grave in un paese leader che ha deciso di reagire all'11 settembre rovesciando i regimi nemici o comunque infidi nel mondo islamico. Ma senza sapere bene come sostituirli con regimi più democratici e contemporaneamente più filoamericani.
Sull'Iraq esiste un consenso di fondo fra gli schieramenti politici sulla necessità di riportare a casa i soldati entro l'anno. Non è di per sé una strategia, ma almeno è una scelta. Ma il diavolo sta nel dettaglio. Sarà solo un cambio di cappello fra una missione militare e una civile, con una copertura militare comunque non indifferente? Quando toccherà esaminare questo capitolo, probabilmente le differenze in seno al centro-sinistra riesploderanno. Sarebbe utile prevenire una simile crisi, definendo pubblicamente che cosa esattamente stiamo a fare in Iraq e con quali mezzi - anche finanziari - intendiamo sostenere i nostri obiettivi.
Quanto all'Iran, siamo brillantemente riusciti ad autoescluderci dalla pattuglia europea abilitata a trattare con Teheran. Per un paese che intrattiene notevoli, storici rapporti energetici e commerciali con i persiani, è un autogol. Oggi potremmo usare la nostra residua influenza in Europa e in America per spingere a favore di negoziati diretti irano-americani, sola alternativa praticabile e forse efficace all'avventura bellica.
Infine la Palestina. La demonizzazione del nuovo governo palestinese, dopo che abbiamo giustamente insistito sulla necessità di lasciar esprimere quel popolo alle urne, è particolarmente miope. Perché la vittoria di Hamas è soprattutto la sconfitta di una vecchia, corrotta nomenklatura - quella arafattiana - che non poteva in nessun modo essere un interlocutore negoziale perché non rappresentava davvero il suo popolo. Se eviteremo di metterlo all'angolo, scopriremo che il governo attuale è molto meno radicale e molto più pragmatico di quanto non appaia a una lettura superficiale del voto palestinese, espresso fra l'altro da quelle stesse persone che l'anno prima avevano scelto Abu Mazen.
Dopo l'esperienza piuttosto deprimente degli ultimi anni forse è troppo ottimistico sperare che l'Italia si riprofili nella competizione internazionale in modo così netto e autorevole. Ma il tempo lavora contro di noi. Perché recuperare una credibilità perduta sarà forse l'opera di due o tre generazioni. E qualcuno dovrà pur cominciare.