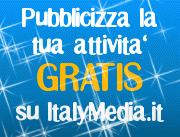Bye Bye George
- Dettagli
di Enrico Pedemonte
L'America delle donne. Dalle elezioni di mid term la leadership del presidente Usa esce azzoppata. I democratici sognano la Casa Bianca nel 2008. Intanto il dopo Bush ha il volto di Nancy Pelosi e di Hillary Clinton. E dice no alla politica neocon e alla guerra in Iraq George W. Bush
Hillary Clinton o Barack Obama? La sera di martedì 7 novembre, mentre la vittoria democratica si faceva più netta, i volti delle due star della politica americana si alternavano sui network televisivi. Hillary parlava alla folla dall'alto del clamoroso successo registrato nello Stato di New York, dove ha sfiorato il 70 per cento dei voti. Obama concedeva interviste nella sua veste di carismatico ragazzo prodigio della politica Usa. Chi dei due sarà il futuro candidato dei progressisti alla presidenza degli Stati Uniti? "La vittoria democratica apre con largo anticipo la campagna elettorale del 2008", commenta Joshua Muravchik, intellettuale dell'American Enterprise Institute, fortino neoconservatore a Washington: "Si apre un periodo di paralisi della politica americana in cui i due partiti cercheranno di posizionarsi per le prossime elezioni presidenziali". Gli fa eco Jonathan Schell, direttore del settimanale della sinistra radicale 'The Nation': "Sarà una campagna lunga, aspra, sgradevole, accanita".
In un paese lacerato dalle divisioni, gli esperti dei due partiti sono concordi nel prevedere due anni di stallo alla Casa Bianca, con il Congresso paralizzato e una campagna elettorale permanente da qui alla fine del 2008. La luna di miele di George W. Bush con gli americani è finita. Il presidente ha governato per cinque anni sfruttando l'effetto choc dell'11 settembre, ha ricevuto due cambiali in bianco dagli elettori, nel 2002 e nel 2004, ma il 7 novembre ha subito una sconfitta bruciante e oggi si presenta ai suoi elettori con lo sguardo smarrito dell'anatra zoppa, consapevole di essere il principale responsabile di una débâcle storica.
Dopo 12 anni, i democratici riconquistano una solida maggioranza alla Camera, dove si è votato per rinnovare tutti i 435 deputati. E anche al Senato, dove è stato rinnovato solo un terzo dei rappresentanti, dovrebbe emergere una risicata maggioranza democratica (51 a 49) dopo il riconteggio dei voti della Virginia. I repubblicani vedono svanire il sogno accarezzato fin dall'inizio degli anni Novanta, quello di creare nel paese una 'maggioranza permanente' grazie all'egemonia sugli Stati del sud e sulla potente destra religiosa. Quel sogno si è dissolto con il fallimento della guerra in Iraq e i troppi scandali nelle file del partito.
Ma sarebbe sbagliato pensare che il terremoto elettorale del 7 novembre porterà a un radicale ripensamento della politica irachena. "Nonostante la vittoria dei democratici, la politica estera degli Stati Uniti, che è nelle mani del presidente, cambierà in modo molto marginale", prevede David Rohde, politologo e docente alla Michigan State University. In teoria il Congresso potrebbe bloccare i finanziamenti alla missione irachena, come accadde negli anni Ottanta per il Vietnam, "ma è improbabile che i democratici facciano una scelta simile", dice Rohde.
Nei prossimi due anni ogni scelta sarà condizionata dai calcoli elettorali per la vittoria nel 2008 e i democratici avranno tutto l'interesse a far cuocere il presidente a fuoco lento nell'inferno di Baghdad, per rendere evidente il fallimento di una strategia che ha isolato gli Stati Uniti a livello internazionale e ha trasformato l'Iraq in un terreno di reclutamento per i terroristi. Se i democratici usassero il loro nuovo potere al Congresso per strangolare economicamente la missione irachena, sarebbero additati come i responsabili degli insuccessi della guerra, accusati di essere antipatriottici e questo porterebbe a un disastro nel 2008.
"La politica estera degli Stati Uniti non cambierà", afferma Muravchik: i democratici chiederanno le dimissioni di Donald Rumsfeld, ma il presidente terrà duro anche su questo punto, perché cacciare il pur discusso ministro della Difesa sarebbe l'ammissione di un fallimento: "Forse Bush dovrebbe allontanarlo, ma non credo che voglia. Ed è forse troppo tardi per farlo", dice Muravchik.
I democratici non hanno interesse a forzare la mano al presidente cercando di condividere il peso di una nuova politica. Molto meglio trasformare il Congresso in un palcoscenico per mettere sotto accusa l'amministrazione: "La Camera a maggioranza democratica diventerà una platea per criticare la politica di Bush e la guerra in Iraq", prosegue Muravchik. I democratici faranno esattamente quello che i repubblicani fecero negli anni Novanta, quando conquistarono la maggioranza al Congresso e cominciarono ad aprire commissioni di inchiesta sugli argomenti più futili, per esempio gli investimenti immobiliari e le vecchie amanti del presidente. E oggi ci sono temi ben più seri da mettere sotto osservazione: "Nei prossimi due anni i democratici avranno il potere di aprire inchieste parlamentari sulla corruzione in Iraq e sulle prigioni segrete, sull'uso della tortura e gli errori dell'intelligence, sulla gestione dell'uragano Katrina a New Orleans e sui finanziamenti bellici", dice John Fonte, analista del conservatore Hudson Institute. Saranno chiamati a testimoniare centinaia di funzionari pubblici e membri dell'amministrazione, e saranno accesi i riflettori sugli errori e lo strapotere della presidenza Bush dopo l'11 settembre.
Gli analisti escludono che i democratici abbiano intenzione di arrivare all'impeachment del presidente, come fecero i repubblicani con Bill Clinton. "Sarebbe un suicidio", nota Muravchik: "La maggioranza degli americani sarebbe contraria, come lo fu ai tempi di Clinton".
D'altra parte non c'è da aspettarsi scelte troppo radicali da parte dei nuovi congressisti democratici: "L'asse del partito si è certamente spostato su posizioni più moderate", racconta Larry Sabato, docente di Scienze politiche all'Università della Virginia: "Una delle conseguenze di queste elezioni è che un gran numero di democratici conservatori sono stati eletti al Congresso, specie alla Camera. Oggi il partito è meno radicale di ieri, specie sulle politiche sociali". Molti dei nuovi eletti sono contro il matrimonio gay, contro l'aborto, e si oppongono al controllo nella vendita delle armi, tradizionale cavallo di battaglia dei progressisti americani. "È esattamente quello che i democratici devono fare se vogliono vincere le elezioni del 2008", dice Sabato, convinto che la Casa Bianca si conquisti puntando all'elettorato di centro.
Il partito che due anni fa nominò John Kerry per la corsa alla presidenza è cambiato profondamente, e lo stesso Kerry è ormai su posizioni di debolezza. È opinione diffusa che l'ex candidato democratico si sia involontariamente autoeliminato dalla scena una settimana fa, quando si è lasciato scappare un'incredibile gaffe durante un comizio. Rivolgendosi a un gruppo di giovani, li ha invitati a studiare sodo: "Altrimenti vi manderanno in Iraq", ha ammonito con fastidiosa ironia. È stato accusato di avere insultato i soldati americani che rischiano la vita a Baghdad, trattandoli da ignoranti, ed è stato obbligato a presentare pubbliche scuse. "Ho parlato con diversi esponenti democratici", racconta Sabato: "Sono tutti furiosi con Kerry e lo considerano ormai fuori dal gioco. Con il suo linguaggio ha di fatto spiegato perché non è stato eletto nel 2004 e perché non potrà essere il candidato nel 2008".
Anche se i rappresentanti democratici al Congresso sono più moderati di ieri, lo scontro tra i due partiti è destinato a diventare sempre più acceso: "La polarizzazione della politica americana non potrà che aumentare, perché nasce da divisioni profonde tra gli elettori e soprattutto tra gli attivisti dei due partiti", dice Rohde.
In questa situazione è prevedibile che Bush sarà ridotto all'impotenza negli ultimi due anni del suo mandato: "Niente piu tagli alle tasse, niente più riforma della sicurezza sociale: la politica interna è morta per due anni", prevede Gary Jacobson, professore di Scienze politiche all'Università di California a San Diego. Tra i grandi temi di politica interna ce n'è uno solo in cui sembra possibile un compromesso tra i democratici e il presidente: l'immigrazione. Molti prevedono un accordo per garantire un'amnistia ai 12 milioni di clandestini che vivono negli Stati Uniti. Ma la maggioranza dei repubblicani è contraria e non è detto che il presidente abbia voglia di sfidare il suo partito su una questione così delicata.
Già oggi il presidente viene considerato un elemento di debolezza da molti repubblicani. La misura del suo isolamento Bush l'ha avuta lunedì 6 novembre, il giorno prima delle elezioni, quando si è recato a Panhandle, in Florida, per dare una mano al candidato governatore Charlie Crist. Arrivato sul palco davanti a 10 mila persone, assieme alla moglie Laura, al fratello Jeb e al suo stratega Karl Rove, ha scoperto che Crist non c'era. Il candidato repubblicano aveva deciso di andare altrove a fare campagna elettorale, trattando il presidente come un appestato.
Con il gradimento ben al di sotto del 40 per cento e un Congresso ostile, difficilmente Bush potrà risalire la china. "Per aumentare il proprio vantaggio i democratici devono lasciarlo governare per due anni. A meno che la guerra in Iraq non si trasformi miracolosamente in un successo, questo porterà a un progressivo indebolimento dei repubblicani", prevede Rohde.
D'altra parte non c'è da aspettarsi scelte troppo radicali da parte dei nuovi congressisti democratici: "L'asse del partito si è certamente spostato su posizioni più moderate", racconta Larry Sabato, docente di Scienze politiche all'Università della Virginia: "Una delle conseguenze di queste elezioni è che un gran numero di democratici conservatori sono stati eletti al Congresso, specie alla Camera. Oggi il partito è meno radicale di ieri, specie sulle politiche sociali". Molti dei nuovi eletti sono contro il matrimonio gay, contro l'aborto, e si oppongono al controllo nella vendita delle armi, tradizionale cavallo di battaglia dei progressisti americani. "È esattamente quello che i democratici devono fare se vogliono vincere le elezioni del 2008", dice Sabato, convinto che la Casa Bianca si conquisti puntando all'elettorato di centro.
Il partito che due anni fa nominò John Kerry per la corsa alla presidenza è cambiato profondamente, e lo stesso Kerry è ormai su posizioni di debolezza. È opinione diffusa che l'ex candidato democratico si sia involontariamente autoeliminato dalla scena una settimana fa, quando si è lasciato scappare un'incredibile gaffe durante un comizio. Rivolgendosi a un gruppo di giovani, li ha invitati a studiare sodo: "Altrimenti vi manderanno in Iraq", ha ammonito con fastidiosa ironia. È stato accusato di avere insultato i soldati americani che rischiano la vita a Baghdad, trattandoli da ignoranti, ed è stato obbligato a presentare pubbliche scuse. "Ho parlato con diversi esponenti democratici", racconta Sabato: "Sono tutti furiosi con Kerry e lo considerano ormai fuori dal gioco. Con il suo linguaggio ha di fatto spiegato perché non è stato eletto nel 2004 e perché non potrà essere il candidato nel 2008".
Anche se i rappresentanti democratici al Congresso sono più moderati di ieri, lo scontro tra i due partiti è destinato a diventare sempre più acceso: "La polarizzazione della politica americana non potrà che aumentare, perché nasce da divisioni profonde tra gli elettori e soprattutto tra gli attivisti dei due partiti", dice Rohde.
In questa situazione è prevedibile che Bush sarà ridotto all'impotenza negli ultimi due anni del suo mandato: "Niente piu tagli alle tasse, niente più riforma della sicurezza sociale: la politica interna è morta per due anni", prevede Gary Jacobson, professore di Scienze politiche all'Università di California a San Diego. Tra i grandi temi di politica interna ce n'è uno solo in cui sembra possibile un compromesso tra i democratici e il presidente: l'immigrazione. Molti prevedono un accordo per garantire un'amnistia ai 12 milioni di clandestini che vivono negli Stati Uniti. Ma la maggioranza dei repubblicani è contraria e non è detto che il presidente abbia voglia di sfidare il suo partito su una questione così delicata.
Già oggi il presidente viene considerato un elemento di debolezza da molti repubblicani. La misura del suo isolamento Bush l'ha avuta lunedì 6 novembre, il giorno prima delle elezioni, quando si è recato a Panhandle, in Florida, per dare una mano al candidato governatore Charlie Crist. Arrivato sul palco davanti a 10 mila persone, assieme alla moglie Laura, al fratello Jeb e al suo stratega Karl Rove, ha scoperto che Crist non c'era. Il candidato repubblicano aveva deciso di andare altrove a fare campagna elettorale, trattando il presidente come un appestato.
Con il gradimento ben al di sotto del 40 per cento e un Congresso ostile, difficilmente Bush potrà risalire la china. "Per aumentare il proprio vantaggio i democratici devono lasciarlo governare per due anni. A meno che la guerra in Iraq non si trasformi miracolosamente in un successo, questo porterà a un progressivo indebolimento dei repubblicani", prevede Rohde.
La sconfitta elettorale ha dunque scompaginato le strategie della destra. "Per vincere le prossime elezioni i repubblicani devono escogitare un'altra formula", nota Schell: "Quella vecchia - spaventare gli elettori usando l'arma propagandistica del terrorismo - non funziona più. Ma non è facile trovare un'alternativa che vada bene per tutte le anime del partito". Anche perché tra i repubblicani ora serpeggia la rivolta. E ognuno interpreta le ragioni della sconfitta a modo suo. Da tempo i neoconservatori spiegano il disastro iracheno con gli errori del presidente nel condurre la guerra, i libertarian non gli perdonano di avere troppo dilatato la spesa pubblica, mentre i conservatori sociali chiedono più convinzione nel lottare contro il matrimonio gay e altre deviazioni etiche.
All'interno del partito, la sconfitta elettorale rafforza la stella del senatore John McCain, l'ex prigioniero del Vietnam che ha obbligato il presidente a scendere a compromessi sulla tortura e sui processi ai terroristi. L'altro candidato forte è Mitt Romney, ex governatore del Massachusetts ed esponente di punta dell'ala conservatrice, amato dalla destra religiosa. Ma tra le diverse ali del partito i contrasti sono destinati a crescere nel corso di una campagna elettorale che sarà lunga, feroce, e sempre più costosa. Dice il Center for Responsive Politics che in queste elezioni i partiti e i candidati hanno bruciato 2,6 miliardi di dollari, una cifra colossale, superiore di un quarto a quella di quattro anni fa. Nel 2008 ne serviranno molti di più: la raccolta fondi è già cominciata.
All'interno del partito, la sconfitta elettorale rafforza la stella del senatore John McCain, l'ex prigioniero del Vietnam che ha obbligato il presidente a scendere a compromessi sulla tortura e sui processi ai terroristi. L'altro candidato forte è Mitt Romney, ex governatore del Massachusetts ed esponente di punta dell'ala conservatrice, amato dalla destra religiosa. Ma tra le diverse ali del partito i contrasti sono destinati a crescere nel corso di una campagna elettorale che sarà lunga, feroce, e sempre più costosa. Dice il Center for Responsive Politics che in queste elezioni i partiti e i candidati hanno bruciato 2,6 miliardi di dollari, una cifra colossale, superiore di un quarto a quella di quattro anni fa. Nel 2008 ne serviranno molti di più: la raccolta fondi è già cominciata.