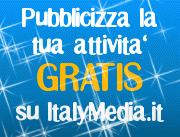Terapia d'urto in corsia
- Dettagli
di Daniela Minerva e Luca Carra
Ricoveri inutili. Abuso di farmaci. Poi Tac e analisi a più non posso. Così lievita la spesa e i malati stanno sempre peggio. Ma il sistema per tagliare c'è. Eccolo Cinque miliardi di euro spesi per ricoverare cittadini che non ne hanno nessun bisogno, che potrebbero cavarsela con un intervento in day hospital, quando non semplicemente con qualche accertamento diagnostico, e invece finiscono a occupare un letto che costa circa 650 euro al giorno. Una follia che le regioni più accorte hanno smascherato, chiedendosi cosa si celasse dietro ragioni di ricovero del tipo 'alterazioni dell'equilibrio' (50 mila nel 2003) , 'ipertensione' (110 mila), 'malattie dell'apparato digerente senza conseguenze' (283 mila), e intervenendo sulle strutture ospedaliere di modo da abbatterle drasticamente. Li chiamano i '43 Drg non appropriati', burocratese per indicare che quel tipo di ricoveri non si deve fare. Questo è avvenuto in Emilia Romagna, in Toscana, in Veneto, in Fiuli, in Umbria e nelle Marche. Ma non nel Lazio, in Sicilia o in Campania. Una prassi stigmatizzata dal Dpf di Tommaso Padoa-Schioppa quando parla dell'"utilizzo improprio dei ricoveri ospedalieri" come uno degli elementi di criticità che il servizio sanitario deve correggere. Insieme all'"inappropriatezza di alcune prestazioni", alla "carenza di servizi di assistenza domiciliare integrata; l'esorbitante livello di spesa farmaceutica per abitante e l'insufficiente qualità dei servizi sanitari in alcune Regioni".
Il Dpf così sintetizza la profonda trasformazione che ha scosso le strutture sanitarie italiane dal 2001 a oggi, sotto la doppia spinta della attribuzione alle regioni della tutela della salute, e della necessità di porre un tetto a una spesa che da anni cresceva all'impazzata e che supera ormai i 95 miliardi di euro l'anno. Per colpa essenzialmente di tre voci di bilancio: ospedali (che in media assorbono il 49 per cento del budget), farmaci (circa il 13) e diagnostica (circa il 20), la nuova bestia nera degli assessori perché sempre più costosa e ambita dai cittadini che prendono molto sul serio i richiami a controllarsi, controllarsi, controllarsi.
Le scelte messe in campo dalle diverse regioni sono oggi una lente d'ingrandimento che rivela impietosamente chi ha ragione e chi ha torto, chi ha vinto e chi ha perso nella partita di tagliare le spese sanitarie rispettando il mandato costituzionale di garantire a tutti i cittadini pari diritti sanitari. Con un effetto paradosso assai sorprendente: gli atlanti della mortalità e della frequenza delle malattie in Italia mostrano che dove si spende meno si vive meglio e più a lungo. L'eccellenza abita in Emilia, in Toscana, nelle Marche, in Veneto. I cittadini soffrono nel Sud del paese, nelle campagne lombarde e piemontesi.
Oggi, la montagna di dati messi a disposizione dall'Agenzia per i servizi regionali smentisce clamorosamente chi invoca generiche ragioni a sprechi e inefficienze. Rivela perché esplode la spesa sanitaria e come la si può controllare con una chiarezza cristallina. A partire dalla favola dell'invecchiamento della popolazione che sarebbe la causa ineluttabile dell'aumento dei costi, ma che nei fatti, commenta Cesare Cislaghi, responsabile dell'Osservatorio di economia dell'Agenzia sanitaria Toscana, "comincerà a incidere seriamente tra diversi anni. Quello che ora ci fa saltare il banco è il consumismo sanitario". Ovvero la passione degli italiani per la diagnostica tanto tecnologicamente avanzata quanto costosa; la fame smisurata di farmaci; ma soprattutto l'incapacità di molte regioni di accompagnare le politiche di rigore alla cosiddetta 'territorializzazione', ovvero la responsabilizzazione dei medici di base, la costruzione di servizi a domicilio e il conseguente svuotarsi degli ospedali.
"In sanità la domanda è praticamente illimitata. Moltiplicare l'offerta significa ineluttabilmente spingere il cittadino a consumare", commenta Giovanni Bissoni, assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. Prendiamo la risonanza magnetica nucleare (Rmn), un accertamento diagnostico altamente specifico e molto costoso: nel Lazio, le Rmn sono duplicate nel giro di quattro anni (dal 2001 al 2005). Con le sue 340.558 Rmn l'anno il Lazio batte tutti i record tanto più che la passione per la risonanza non esclude gli altri accertamenti (Tac, ecografie, mammografie) che ugualmente crescono seppur non in maniera così drammatica. L'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio annota :"Le prestazioni di Rmn sono state erogate principalmente dal comparto privato provvisoriamente accreditato", vale a dire proprio quel comparto noto alle cronache giudiziarie per una serie di scandali che vanno da Lady Asl alla Panigea di Daniela Fini. Comparto che è esploso nell'ultimo quinquennio della giunta Storace: 21 le strutture per le risonanze presenti nel Lazio nel 2000, 49 attive nel 2005 di cui 17 private che da sole hanno erogato oltre i 2/3 degli esami, 232 mila su 340 mila. L'equazione è semplice: più risonanze, Tac, e simili si mettono a disposizione dei cittadini, più questi ne usufruiscono. Utili o inutili che siano. "Noi non abbiamo avuto la mano leggera sul fronte dell'accreditamento di strutture private," commenta Bissoni da Bologna: "Le Rnm e le Tac collocate negli ospedali sono di gran lunga sufficienti per far fronte al bisogno della popolazione. Quelle in più non fanno altro che stimolare il cittadino a fare esami inutili".
A largheggiare nell'offerta sono in particolar modo le regioni che hanno puntato sul privato: la Regione Lombardia ha analizzato gli esami svolti dal 1997 al 2003 e scoperto che, mentre le vecchie radiografie sono rimaste pressoché stabili negli anni, le Tac sono raddoppiate nelle strutture private accreditate e le Rmn triplicate. Tutte utili? Sempre la Regione Lombardia ha tirato le somme della diagnostica eseguita nel 2004: ben 148 milioni tra esami del sangue, ecocardiogrammi, Tac, e così via, per un costo totale di 1,8 miliardi di euro, e ne ha studiato i risultati: l'80 per cento degli accertamenti ha dato esito negativo. E ancora: uno studio dei cardiologi ospedalieri ha mostrato che i medici sempre più prescrivono senza un vero perché gli elettrocardiogrammi da sforzo, test costosi che dovrebbero essere preceduti da una valutazione di rischio del paziente. È quella che gli addetti ai lavori chiamano 'inappropriatezza della diagnostica': esami a vuoto, prescritti per sintomi per i quali non sarebbero indicati, che fanno salire il deficit dei bilanci. E se il caso delle risonanze brilla perché coinvolge un'indagine complessa e costosa, la voce che viene definita a 'maggior rischio di inappropriatezza' sono i cosiddetti esami del sangue. Esami dai costi spropositati perché la politica dell'accreditare ogni centro privato implica - oltre che il moltiplicarsi dell'offerta e il conseguente consumismo - un proliferare di laboratori. "Che costano inutilmente. Meglio accentrare: in Romagna la prassi è quella di avere tanti punti per i prelievi e un unico laboratorio di analisi che serve un milione di cittadini", si vanta Bissoni. Che conclude: "Il nostro problema non è aprire centri diagnostici, ma chiuderli".
È ancora una volta la regionalizzazione a fornire la lente d'ingrandimento: da un lato chi ha puntato sul privato accreditando a man bassa e spingendo al consumo, dall'altro le 'regioni rosse' che stringono i cordoni: poca offerta, consumo controllato. In Toscana hanno deciso di erogare le prestazioni sulla base dell'utilità dell'esame per ogni paziente: liste d'attesa differenziate a seconda della gravità e dell'urgenza. L'obiettivo è spostare risorse e personale sui test più utili e rieducare i medici, abituati ormai a prescrivere in prima battuta esami da riservare a ulteriori approfondimenti, come la risonanza per un mal di schiena. Ma anche il pubblico verrà responsabilizzato dalle nuove regole regionali in vigore da giugno: chi non si presenterà alla visita dopo averla prenotata o non ritirerà il referto di un'indagine diagnostica, dovrà pagare il ticket.
A largheggiare nell'offerta sono in particolar modo le regioni che hanno puntato sul privato: la Regione Lombardia ha analizzato gli esami svolti dal 1997 al 2003 e scoperto che, mentre le vecchie radiografie sono rimaste pressoché stabili negli anni, le Tac sono raddoppiate nelle strutture private accreditate e le Rmn triplicate. Tutte utili? Sempre la Regione Lombardia ha tirato le somme della diagnostica eseguita nel 2004: ben 148 milioni tra esami del sangue, ecocardiogrammi, Tac, e così via, per un costo totale di 1,8 miliardi di euro, e ne ha studiato i risultati: l'80 per cento degli accertamenti ha dato esito negativo. E ancora: uno studio dei cardiologi ospedalieri ha mostrato che i medici sempre più prescrivono senza un vero perché gli elettrocardiogrammi da sforzo, test costosi che dovrebbero essere preceduti da una valutazione di rischio del paziente. È quella che gli addetti ai lavori chiamano 'inappropriatezza della diagnostica': esami a vuoto, prescritti per sintomi per i quali non sarebbero indicati, che fanno salire il deficit dei bilanci. E se il caso delle risonanze brilla perché coinvolge un'indagine complessa e costosa, la voce che viene definita a 'maggior rischio di inappropriatezza' sono i cosiddetti esami del sangue. Esami dai costi spropositati perché la politica dell'accreditare ogni centro privato implica - oltre che il moltiplicarsi dell'offerta e il conseguente consumismo - un proliferare di laboratori. "Che costano inutilmente. Meglio accentrare: in Romagna la prassi è quella di avere tanti punti per i prelievi e un unico laboratorio di analisi che serve un milione di cittadini", si vanta Bissoni. Che conclude: "Il nostro problema non è aprire centri diagnostici, ma chiuderli".
È ancora una volta la regionalizzazione a fornire la lente d'ingrandimento: da un lato chi ha puntato sul privato accreditando a man bassa e spingendo al consumo, dall'altro le 'regioni rosse' che stringono i cordoni: poca offerta, consumo controllato. In Toscana hanno deciso di erogare le prestazioni sulla base dell'utilità dell'esame per ogni paziente: liste d'attesa differenziate a seconda della gravità e dell'urgenza. L'obiettivo è spostare risorse e personale sui test più utili e rieducare i medici, abituati ormai a prescrivere in prima battuta esami da riservare a ulteriori approfondimenti, come la risonanza per un mal di schiena. Ma anche il pubblico verrà responsabilizzato dalle nuove regole regionali in vigore da giugno: chi non si presenterà alla visita dopo averla prenotata o non ritirerà il referto di un'indagine diagnostica, dovrà pagare il ticket.
Quella di convincere i medici a prescrivere davvero solo ciò che serve è la ricetta scelta sia in Toscana che in Emilia per cercare di controllare la spesa farmaceutica: "Il rischio è quello che il cittadino viva la necessità di evitare gli sprechi come la privazione di un diritto", spiega Bissoni: "Non possiamo semplicemente punire i medici che prescrivono troppo o che indicano farmaci troppo costosi, dobbiamo decidere insieme a loro come e quando un medicinale è appropriato". La faccenda delle prescrizioni selvagge è assai semplice: l'analisi delle ricette ha evidenziato ovunque che esse non corrispondono all'epidemiologia, ovvero alla stima della distribuzione dei malanni sul territorio. Questo accade innanzitutto perché i medici prescrivono più sulla base delle novità che arrivano sul mercato, spinte fortissimamente dalle aziende, che non sui veri bisogni dei loro malati, e poi perché sono i pazienti stessi a chiedere sempre se c'è qualcosa di meglio, di più forte. Altrimenti non si spiegherebbe perché nel nostro paese si consumino valanghe di antibiotici di terza generazione potenti e costosi per malanni banali come otiti o faringiti; perché si contrasti la comune ipertensione con molecole raffinate come i sartani o gli ace-inibitori; perché si indulga in burri e carni rosse per poi abbattere il colesterolo con le statine: come dimostra un rapporto allarmato dell'Agenzia per i servizi regionali fatto insieme al Cnr. Sono proprio questi comportamenti a essere oggi nel mirino delle autorità; e lo spreco ha assunto dimensioni tali che le stesse aziende farmaceutiche sono chiamate a risarcire il Servizio sanitario nazionale quando si registri un eccesso di consumi non giustificato dalle rilevazioni degli epidemiologi.
Anche sul fronte medicinali le diverse ricette regionali hanno dato risposte precise: in Lazio, Puglia, Campania e Sicilia la spesa farmaceutica continua a crescere, Lombardia ed Emilia Romagna, l'una coi ticket e l'altra con la responsabilizzazione dei medici, hanno diminuito i consumi. E molto di più si potrebbe fare: ogni cittadino emiliano-romagnolo spende in media 192 euro l'anno in medicine, che è abbastanza poco, considerando che un laziale ne spende 306, un siciliano 300, ma che è tanto se rapportato al consumo di un abitante di Reggio Emilia: "Se in tutta la regione ci comportassimo come a Reggio, in un anno risparmieremmo 80 milioni di euro", considera Bissoni. Come a dire che margine per tagliare ce n'è parecchio.
Anche sul fronte medicinali le diverse ricette regionali hanno dato risposte precise: in Lazio, Puglia, Campania e Sicilia la spesa farmaceutica continua a crescere, Lombardia ed Emilia Romagna, l'una coi ticket e l'altra con la responsabilizzazione dei medici, hanno diminuito i consumi. E molto di più si potrebbe fare: ogni cittadino emiliano-romagnolo spende in media 192 euro l'anno in medicine, che è abbastanza poco, considerando che un laziale ne spende 306, un siciliano 300, ma che è tanto se rapportato al consumo di un abitante di Reggio Emilia: "Se in tutta la regione ci comportassimo come a Reggio, in un anno risparmieremmo 80 milioni di euro", considera Bissoni. Come a dire che margine per tagliare ce n'è parecchio.