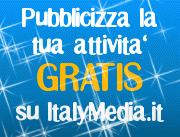Fermiamo Bush
- Dettagli
di Roberto Di Caro
Una guerra sciagurata. E una immagine internazionale incrinata. L'atto di accusa di Madeleine Albright, ex segretario di Stato di Clinton. Alla vigilia di un voto decisivo per il presidente degli Stati Uniti George W. Bush
Abig mistake, a huge tragedy. Un grave errore, una enorme tragedia: questa è stata, per Madeleine Albright, la guerra in Iraq. A una cena la sera prima dell'intervista aveva citato 'La Tempesta' e le era quasi scappato: "In Iraq neanche Shakespeare riuscirebbe a vincere". Il problema, dunque, è solo come uscirne senza perdere del tutto la guerra e la faccia. Ma "è molto difficile: buone soluzioni non ce ne sono". Che un ex segretario di Stato, la prima donna a ricoprire tale carica con Bill Clinton presidente dal 1997 al 2001, dica cose del genere alla vigilia delle elezioni di 'mid term' e per giunta in un paese straniero, è per un'americana, ancorché nata in Cecoslovacchia ed emigrata negli States nel 1948 con il padre diplomatico, uno strappo alle rigide regole di comportamento ammesse dall'establishment come dal sentire comune. E ciò dà la misura, oltre che della determinazione della Albright, anche di quanto sia grave la crisi di coscienza di un'America ancora due anni fa abbastanza compatta, per patriottismo o per attendismo, nel sostenere la politica irachena di Bush, e ora lacerata dal peggior senso di frustrazione dai tempi della guerra del Vietnam. L'intervista alla signora Albright (ora professore di Diplomazia alla Georgetown School of Foreign Service, presidente del National Democratic Institute for International Affairs, imprenditrice con la sua società di negoziazione internazionale Albright Group) si è svolto al World Business Forum organizzato a Milano da Hsm, azienda multimedia di 'executive education', mega-seminari per manager con i grandi della politica e dell'economia mondiale.Signora Albright, che cosa cambierà dopo le elezioni di mid-term se, come tutti i sondaggi annunciano, voi democratici riconquisterete la maggioranza nel Congresso e forse al Senato?
"Il Congresso tornerà a svolgere il suo ruolo fondamentale di controllo dell'esecutivo. La nostra non è una 'democrazia imperiale': la Costituzione prevede un sistema di bilanciamento dei poteri. Invece di accettare tutto ciò che il presidente vuole e fa, i vari comitati supervisionano l'operato del ministero della Difesa, degli Esteri e così via, convocano esperti in speciali audizioni, mettono in discussione il budget, le intenzioni, le strategie. Purtroppo negli ultimi sei anni ciò non è avvenuto: come in qualunque paese, non c'è discussione se un unico partito controlla tutto. Ora ci sarà molta più democrazia".
C'è il rischio di una paralisi istituzionale?
"Avremo forse qualche impasse per eccesso di dibattito. Ma è la democrazia".
Il presidente Bush sarà costretto a cambiare radicalmente la politica sull'Iraq?
"È presto per dirlo. Certo i democratici, con poche eccezioni, sono uniti sul fatto che in un modo o nell'altro la guerra deve finire".
Ma non sul come...
"Ci sono disaccordi sulla data del ritiro. Ma il fatto rilevante è che in questa campagna elettorale un certo numero di repubblicani hanno preso posizione per il ritiro: incluso John William Warner, senatore della Virginia e presidente del Commettee on Armed Services".
Nonché 200 militari in servizio attivo...
"Ne ho solo letto. È un fatto inusuale, sì".
Lei ha di recente partecipato a un meeting ristretto sull'Iraq con il presidente Bush. Quale cambio di strategia si profila? Fallita ogni altra soluzione, si considera l'ipotesi di una tripartizione dell'Iraq su base etnica?
"Nell'incontro non è emersa, e personalmente ritengo non sia una buona idea: per l'instabilità dell'area e per le prevedibili reazioni di Turchia e Iran. Si discute piuttosto di attribuire maggiore autonomia alle diverse aree, mantenendo uno Stato centrale e garantendo un'equa distribuzione degli introiti del petrolio".
Ma ciò significherebbe mantenere le attuali milizie etniche, i peshmerga dei curdi, quelle sciite del Mahdi e dello Sciri...
"È questo il problema: senza un esercito centrale bene organizzato, formare soldati significa insegnare a combattersi tra loro".
E dunque, che fare?
"Gli altri paesi devono aiutarci. Gli Stati Uniti non hanno scatenato né la Prima né la Seconda guerra mondiale, ma quando hanno capito che i loro interessi nazionali venivano messi in gioco sono intervenuti. Lo stesso credo debbano fare ora i paesi europei, anche se in maggioranza erano contrari alla guerra: formando tecnici, soldati, poliziotti, intervenendo nella ricostruzione...".
C'è il rischio di una paralisi istituzionale?
"Avremo forse qualche impasse per eccesso di dibattito. Ma è la democrazia".
Il presidente Bush sarà costretto a cambiare radicalmente la politica sull'Iraq?
"È presto per dirlo. Certo i democratici, con poche eccezioni, sono uniti sul fatto che in un modo o nell'altro la guerra deve finire".
Ma non sul come...
"Ci sono disaccordi sulla data del ritiro. Ma il fatto rilevante è che in questa campagna elettorale un certo numero di repubblicani hanno preso posizione per il ritiro: incluso John William Warner, senatore della Virginia e presidente del Commettee on Armed Services".
Nonché 200 militari in servizio attivo...
"Ne ho solo letto. È un fatto inusuale, sì".
Lei ha di recente partecipato a un meeting ristretto sull'Iraq con il presidente Bush. Quale cambio di strategia si profila? Fallita ogni altra soluzione, si considera l'ipotesi di una tripartizione dell'Iraq su base etnica?
"Nell'incontro non è emersa, e personalmente ritengo non sia una buona idea: per l'instabilità dell'area e per le prevedibili reazioni di Turchia e Iran. Si discute piuttosto di attribuire maggiore autonomia alle diverse aree, mantenendo uno Stato centrale e garantendo un'equa distribuzione degli introiti del petrolio".
Ma ciò significherebbe mantenere le attuali milizie etniche, i peshmerga dei curdi, quelle sciite del Mahdi e dello Sciri...
"È questo il problema: senza un esercito centrale bene organizzato, formare soldati significa insegnare a combattersi tra loro".
E dunque, che fare?
"Gli altri paesi devono aiutarci. Gli Stati Uniti non hanno scatenato né la Prima né la Seconda guerra mondiale, ma quando hanno capito che i loro interessi nazionali venivano messi in gioco sono intervenuti. Lo stesso credo debbano fare ora i paesi europei, anche se in maggioranza erano contrari alla guerra: formando tecnici, soldati, poliziotti, intervenendo nella ricostruzione...".
Lo fanno dal 2003.
"Penso dovrebbero impegnarsi di più".
E come? In un paese segnato da stragi quotidiane è quasi impossibile. A differenza dell'Afghanistan, la guerra in Iraq ha di fatto regalato il paese metà all'Iran e metà ad Al Qaeda.
"Sì, ne convengo: è stato un grave errore, una enorme tragedia".
Ritiene che in queste condizioni gli Stati Uniti si debbano ritirare il più presto possibile?
"Sono contraria a indicare una data: gli iracheni dovranno dirci quando saranno pronti. È comprensibile che non vogliano essere gestiti da altri, ma è interesse reciproco creare al più presto le condizioni perché gli Usa possano lasciare l'Iraq".
Non possono restare e non possono lasciare?
"È una situazione molto difficile. La verità è che buone soluzioni non ce ne sono".
Lei è da sempre a favore dell'engagement, dell'impegno del suo paese nel mondo. Vede nella delusione dell'americano medio la tentazione di un nuovo isolazionismo?
"Sono preoccupata, sì. Dopo esserci infilati in una cattiva guerra, con la paura di ripercussioni e mezzo mondo che dice cose terribili di noi, è umano che molti americani pensino: meglio restare dentro i nostri confini e badare ai fatti nostri. È importantissimo che il prossimo presidente faccia comprendere sempre più come il mondo sia strettamente interdipendente e ognuno abbia bisogno degli altri, di petrolio, di mercati, di vendere e di importare".
Il prossimo presidente chi? Hillary Clinton?
"Beh, è il mio candidato. È una donna in gamba e un politico di prim'ordine: non ha certo passato il suo tempo alla Casa Bianca a organizzare party".
E Barack Obama, senatore dell'Illinois e astro nascente dei democratici?
"Una nuova stella, è vero. L'ho incontrato alla Convention democratica di Boston e in effetti è una persona assai interessante, gradevole, dinamico, che lavora sodo. Un potenziale in più, per i democratici".
'The Mighty and the Almighty', il potente e l'Onnipotente, il suo ultimo libro appena uscito per i tipi della Macmillan, scandaglia il nuovo ruolo giocato dalla religione sullo scenario mondiale. Ma il tema riguarda non solo l'Islam: anche l'America del presidente Bush.
"Ho lavorato con due presidenti, Carter e Clinton, entrambi profondamente religiosi: ma il loro credo non è mai diventato direttamente politica. 'Noi guardiamo le cose in uno specchio oscuro', amava dire Clinton: intendeva che in questo mondo non ci è dato conoscere sempre e per intero la verità. Il presidente Bush, invece, è sempre così sicuro dei suoi convincimenti che trasforma automaticamente ogni sua credenza in azione politica".
Un'anomalia persino per la religiosa America?
"A parte il presidente William McKinley (1897-1901, che inviò le truppe a 'cristianizzare e civilizzare' le Filippine, ndr) direi di sì. L'amministrazione Bush è andata in guerra senza neanche porsi delle domande: e ciò ha a che fare con le sue forti convinzioni religiose. 'Dio è dalla nostra parte', ripete Bush. Lincoln diceva: 'Dobbiamo stare dalla parte di Dio'".
Gli Stati Uniti sono in grado di fermare l'atomica iraniana? Se sì, come? Se no, perché?
"Io credo che gli Stati Uniti dovrebbero parlare direttamente con l'Iran. Ora è difficile perché abbiamo posto tutta una serie di precondizioni che l'Iran non ha soddisfatto. Ma si è espresso in tal senso anche l'ex segretario di Stato James Baker: discutere con un altro paese, ha detto, non è un segno di debolezza. Solo l'azione internazionale congiunta può però riuscire a fermare il presidente Ahmadinejad".
E Cina e Russia sono tiepidissimi su qualunque azione contro l'Iran, incluse le sanzioni.
"Già. I paesi che hanno petrolio vogliono armi, e quelli che hanno armi hanno bisogno di petrolio. Uno scenario complesso".
Il test nucleare nord-coreano non lascia ben sperare sulla forza della diplomazia. Come segretario di Stato lei ha avuto un ruolo chiave nelle trattative con quel paese. Cosa ne pensa?
"È un paese molto pericoloso. Noi ci muovemmo sulla base della politica dell'allora presidente della Corea del Sud, Kim Dae Jung e ottenemmo una moratoria sui missili e una temporanea sospensione del programma nucleare. Ora Kim sollecita negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Corea del Nord. Dovremmo seguire il consiglio".
"Penso dovrebbero impegnarsi di più".
E come? In un paese segnato da stragi quotidiane è quasi impossibile. A differenza dell'Afghanistan, la guerra in Iraq ha di fatto regalato il paese metà all'Iran e metà ad Al Qaeda.
"Sì, ne convengo: è stato un grave errore, una enorme tragedia".
Ritiene che in queste condizioni gli Stati Uniti si debbano ritirare il più presto possibile?
"Sono contraria a indicare una data: gli iracheni dovranno dirci quando saranno pronti. È comprensibile che non vogliano essere gestiti da altri, ma è interesse reciproco creare al più presto le condizioni perché gli Usa possano lasciare l'Iraq".
Non possono restare e non possono lasciare?
"È una situazione molto difficile. La verità è che buone soluzioni non ce ne sono".
Lei è da sempre a favore dell'engagement, dell'impegno del suo paese nel mondo. Vede nella delusione dell'americano medio la tentazione di un nuovo isolazionismo?
"Sono preoccupata, sì. Dopo esserci infilati in una cattiva guerra, con la paura di ripercussioni e mezzo mondo che dice cose terribili di noi, è umano che molti americani pensino: meglio restare dentro i nostri confini e badare ai fatti nostri. È importantissimo che il prossimo presidente faccia comprendere sempre più come il mondo sia strettamente interdipendente e ognuno abbia bisogno degli altri, di petrolio, di mercati, di vendere e di importare".
Il prossimo presidente chi? Hillary Clinton?
"Beh, è il mio candidato. È una donna in gamba e un politico di prim'ordine: non ha certo passato il suo tempo alla Casa Bianca a organizzare party".
E Barack Obama, senatore dell'Illinois e astro nascente dei democratici?
"Una nuova stella, è vero. L'ho incontrato alla Convention democratica di Boston e in effetti è una persona assai interessante, gradevole, dinamico, che lavora sodo. Un potenziale in più, per i democratici".
'The Mighty and the Almighty', il potente e l'Onnipotente, il suo ultimo libro appena uscito per i tipi della Macmillan, scandaglia il nuovo ruolo giocato dalla religione sullo scenario mondiale. Ma il tema riguarda non solo l'Islam: anche l'America del presidente Bush.
"Ho lavorato con due presidenti, Carter e Clinton, entrambi profondamente religiosi: ma il loro credo non è mai diventato direttamente politica. 'Noi guardiamo le cose in uno specchio oscuro', amava dire Clinton: intendeva che in questo mondo non ci è dato conoscere sempre e per intero la verità. Il presidente Bush, invece, è sempre così sicuro dei suoi convincimenti che trasforma automaticamente ogni sua credenza in azione politica".
Un'anomalia persino per la religiosa America?
"A parte il presidente William McKinley (1897-1901, che inviò le truppe a 'cristianizzare e civilizzare' le Filippine, ndr) direi di sì. L'amministrazione Bush è andata in guerra senza neanche porsi delle domande: e ciò ha a che fare con le sue forti convinzioni religiose. 'Dio è dalla nostra parte', ripete Bush. Lincoln diceva: 'Dobbiamo stare dalla parte di Dio'".
Gli Stati Uniti sono in grado di fermare l'atomica iraniana? Se sì, come? Se no, perché?
"Io credo che gli Stati Uniti dovrebbero parlare direttamente con l'Iran. Ora è difficile perché abbiamo posto tutta una serie di precondizioni che l'Iran non ha soddisfatto. Ma si è espresso in tal senso anche l'ex segretario di Stato James Baker: discutere con un altro paese, ha detto, non è un segno di debolezza. Solo l'azione internazionale congiunta può però riuscire a fermare il presidente Ahmadinejad".
E Cina e Russia sono tiepidissimi su qualunque azione contro l'Iran, incluse le sanzioni.
"Già. I paesi che hanno petrolio vogliono armi, e quelli che hanno armi hanno bisogno di petrolio. Uno scenario complesso".
Il test nucleare nord-coreano non lascia ben sperare sulla forza della diplomazia. Come segretario di Stato lei ha avuto un ruolo chiave nelle trattative con quel paese. Cosa ne pensa?
"È un paese molto pericoloso. Noi ci muovemmo sulla base della politica dell'allora presidente della Corea del Sud, Kim Dae Jung e ottenemmo una moratoria sui missili e una temporanea sospensione del programma nucleare. Ora Kim sollecita negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Corea del Nord. Dovremmo seguire il consiglio".